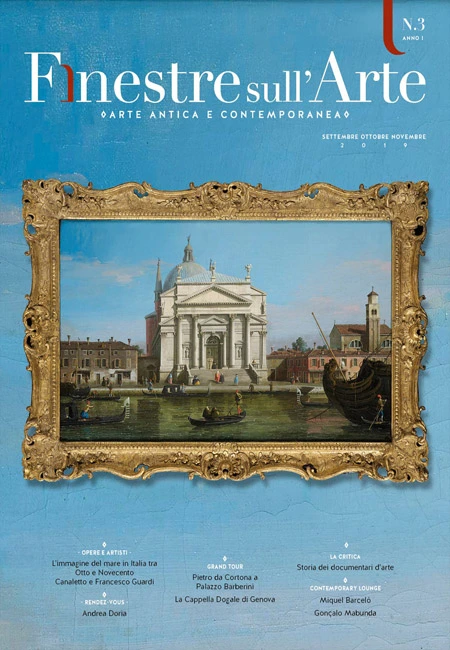Frank Lloyd Wright, la crisi del profeta
Considerava l’architettura il “punto cieco” dell’America. Quel puntino che si muove sulla retina e diventa un disturbo che impediva ai suoi connazionali di vedere bene quanto possa essere importante l’architettura nello sviluppo della società democratica. Per Frank Lloyd Wright era questo il tarlo che doveva spingere l’uomo del XX secolo (ma se fosse vivo direbbe lo stesso all’americano di oggi) a comprendere le leggi che ne regolano la vita collettiva e il modo di abitare la terra prendendole dall’ordine naturale. Ancora oggi la sua profezia di un’architettura “organica”, cioè pensata sulla simbiosi fra spazio umano e natura, non sembra essere ben chiara per le nostre società che pure spendono ingenti capitali ed energie per l’ecologia e la tutela dell’ambiente. L’architettura organica non è una forma di ambientalismo o di romanticismo, nella sua forma è qualcosa di analogo all’antropometria su cui i greci e altre culture fondarono la loro arte del costruire. Anche Wright adopera una metafora legata alla struttura del corpo umano, e nel tentativo di spiegare cosa intende quando parla di pattern naturale, afferma che “è la struttura ossea a essere fatta secondo il pattern del volto. Il volto non è il risultato della struttura ossea, è la struttura che deriva dal pattern del volto. In questo modo la struttura può formare un pattern. Il pattern è l’idea della forma, ed è così in natura come in architettura”. Questo fitomorfismo che comunica le leggi della natura alla struttura architettonica fa sì che The Illinois, il grattacielo alto un miglio, riprenda la forma strutturale di un albero. Ma Wright lo pensa come una sorta di “ornamento totale”, perché la natura stessa “costruisce continuamente pattern”. Ancora una volta Wright contesta l’accademica distinzione che nell’Ottocento aveva dominato fra architetti e ingegneri, dove i primi sono delegati all’esteriorità decorativa, mentre i secondi alla componente tecnologica (dove è sottinteso che gli ingegneri si occupano delle cose fondamentali, mentre l’architetto è una sorta di disegnatore di carte da parati). Ma dev’essere chiaro, osserva appunto Wright, che non il pattern di un edificio, la sua ossatura, determina il volto, ma è la struttura che deriva dal pattern del volto. Non esiste più una vera distinzione tra forma e contenuto, e questa è la visione più anticlassica che si potesse immaginare all’epoca.

Dittatura delle macchine, congestione delle città, arretratezza concettuale che considera la costruzione ancora a partire da schemi ottocenteschi che pensano l’esterno, le facciate, prima di aver organizzato lo spazio interno rispondendo alle esigenze di chi ci deve vivere: la bigness che ha furoreggiato e connotato il panorama urbano di questo lungo inizio del XXI secolo, è stato proprio questo. Una cultura del contenitore fuori scala che ha schiacciato col suo gigantismo ogni pensiero critico dell’uomo comune, in un certo senso violando la corrispondenza che Wright poneva fra architettura e democrazia. Il cambio di sguardo consiste nell’abbandonare l’idea della scatola riempita di tante cose inutili che ci separano dal rapporto col paesaggio, con la scoperta di uno spazio fluido dove non esiste più separazione fra interno ed esterno e tutto scorre in piena libertà realizzando un nuovo ordine di bellezza. Questo è possibile, sosteneva Wright, perché ferro e vetro ci consentono di superare il limite del muro che impedisce quella comunicazione vitale tra lo spazio privato e l’ambiente nel quale si trova. L’architettura organica, insomma, è questa continuità che libera l’uomo ma anche il luogo in cui vive da ogni vincolo autoritario. L’uno e l’altro si completano, al punto che il sacrificio di uno ferisce anche l’altro. Ecco la nuova etica del costruire. Un’etica violata sistematicamente, però, ogni giorno dal real estate contemporaneo.
L’architetto Carlo Nardi ha appena pubblicato un saggio erratico alla ricerca del filo d’Arianna che possa dar ragione di quella che chiama La crisi del profeta (Quodlibet, pagine 180, euro 20). Il profeta, naturalmente, è Wright e la “svolta” si colloca tra 1909 e 1910, quando, superati di poco i quaranta, il Maestro lascia l’America e la famiglia (moglie e sei figli), la casa e lo studio di Oak Park, periferia di Chicago, avendo all’attivo vari edifici che basterebbero, come scrive Nardi, a riservargli un posto nella storia dell’architettura americana; è diretto in Italia e ha deciso di stabilirsi tra Fiesole e Firenze, nella culla del suo nemico, il Rinascimento, che vede come l’apoteosi dell’accademismo – Zevi aveva assimilato dal grande americano una cultura dell’anticlassicismo, di rifiuto della simmetria e di un ordine astratto corrispondente all’armonia classica, e a partire da questo “odio” estetico, finita la guerra, aveva diffuso in Italia il verbo wrightiano –; con questa scelta coraggiosa, e rischiosa, voleva vincere l’apatia in cui era caduto pur esercitando con successo la sua arte.



Wright non era uno che si accontentava. Sapeva di essere un genio, ma soprattutto ne sentiva la vocazione, l’investitura superiore. “Egli”, scrive Nardi, “procede per accrescimento nella sua evoluzione artistica e ogni avanzamento conserva il percorso fatto”. Se dicessimo che Wright, ogni volta che aggiunge una nuova esperienza o una conoscenza guadagnata sul campo, non sta facendo altro che comporre un ritratto più preciso di se stesso, potremmo pensare che questo sia una variante del self made man, ma ci fermeremmo soltanto alla superficie perché la “profezia”, quella che Edoardo Persico espose nella sua celebre conferenza, è più di un’utopia, che forse cartesianamente poteva bastare al teorico modernista Le Corbusier, ma Wright apparteneva a una schiatta americana che aveva fra i suoi “padri” Emerson e Whitman, per i quali la wilderness – che giustamente Nardi ricorda – non è la natura civilizzata, ma quella selvaggia che resta il codice genetico dei pionieri americani. La natura buona, certo, capace di enormi energie, innocente anche nella sua stessa forza soverchiante, ma non buonista come sembrano pensare oggi molti che non hanno lo stesso nerbo del capitano Achab che affronta Moby Dick sapendo che deve aver ragione di quella forza cieca perché questo è il compito degli eroi che cambiano un’epoca. Wright, osserva Nardi, potrebbe rientrare appunto negli Eroi che Thomas Carlyle ritrae nel suo omonimo libro, tra questi anche Dante, e l’eroe appunto “è colui che orienta il mondo del proprio tempo, capace di imprese giganti”.
La megalomania wrightiana è un frutto di un orgoglio di fronte al quale non ti resta che ammettere che lui se lo poteva permettere: “A lui non interessava vedere gli altri”. Tipico dei geni, che poi diventano eroi se confermano le aspettative. Nardi evoca Melville, ma vede in Hugo, nella celebre antitesi ceci tuera cela in Notre-Dame de Paris, il testimone apocalittico smentito dalla elezione di Wright al soglio di “architetto geniale” del XX secolo. Wright non crede che la stampa ucciderà l’architettura, anzi; lui stesso è un forte lettore e proprio negli anni del viaggio in Italia affronta un progetto editoriale che è quasi un monumento bibliografico al proprio genio, si tratta del Portfolio Wasmuth, edito a Berlino nel 1910, composto da cento tavole litografiche che radunano il catalogo delle sue opere principali fino a quel momento. Wright intendeva così dar prova della propria predestinazione che lo investiva del compito di rivelare agli americani che una rivoluzione stava avvenendo e lui era il suo verbo. Così spiegò a un intervistatore che il nome delle Usonian House lo prese in prestito da Samuel Butler, il quale aveva sostenuto che il popolo americano non aveva un nome per il proprio paese e propose di chiamarsi Usonia e usoniani. C’è sempre un valore fondativo nell’esperienza di Wright, qualcosa di battesimale in senso biblico. Resta solo da ricordare la fatalità di un destino fin troppo solerte nel farsi mito quando un rogo, pochi anni dopo, distrusse la prima Taliesin e la maggior parte delle copie del Portfolio.
L’autore del saggio insegue le labili tracce di una verità scritta per così dire fra le righe della biografia wrightiana; cerca di far parlare Wright sperando che si tradisca e confessi i motivi che lo portarono a quel soggiorno nella patria di ciò che sentiva come fumo negli occhi: “Palladio? Bramante? Il Sansovino? Scultori… tutti quanti! Ecco qui ora, invece, Frank Lloyd Wright, il tessitore”. La classicità era, sotto quel profilo, veleno: però Nardi invita a seguire l’intreccio sottocutaneo che rende “occultamente affini” i maestri del Quattro e Cinquecento e l’architetto americano. Bisogna essere meno prevenuti: “proporzione e armonia, bellezza direbbe Wright”. Nardi aveva appena finito di osservare che quell’inizio del Novecento nel quale Wright cerca la sua Thule non erano stati ancora studiati da storici come Ackerman e Wittkover, per cui non sarebbe irragionevole dire che “nel parlare di Rinascimento Wright e i suoi colleghi avevano più in mente le successive rielaborazioni neoclassiche e Beaux-Arts”, e non tanto i maestri del Quattro-Cinquecento italiano. Eppure aveva fatto i nomi: Palladio, Bramante, Sansovino, e li aveva paragonati a scultori. Che fosse un destino dell’architettura europea? In fondo, chi non ha mai pensato almeno una volta che Le Corbusier sia stato un architetto-scultore (fin da quando aveva ideato la Villa Savoye come un solido parallelepipedo semisospeso sul vuoto, circondandola in uno spazio verde alla sommità di un colle parigino).


Nardi prende sempre con le molle le dichiarazioni di Wright, che pesava ogni parola anche quando mentiva. In ogni caso, il rapido ritratto che l’autore ci offre del grande architetto è quello di uno che tiene sempre in pugno l’interlocutore, e diventa subito chiaro che nessuno riuscirà mai a fargli dire qualcosa che non abbia già deciso di dire. Essere sicuri di sé: un imperativo mutuato da Ralph Waldo Emerson che in Fiducia in se stessi scrive: “Credere nel proprio pensiero, credere che ciò che è vero per te, nel tuo cuore, è vero per tutti gli uomini, questo è il genio”. Wright sottoscrive. E diffida di chi attribuisce troppo peso all’educazione, lui che non era laureato. È una filosofia molto americana, pionieristica, contro quella europea del dubbio, dello scetticismo, della messa alla prova ogni volta di una tradizione da confermare, sia pure innovandola.
Nel 1909, quando lascia l’America per l’Italia, Wright è al limite. Nella sua autobiografia confessa: “Stanco, andavo perdendo la capacità di lavorare e persino l’interesse per il mio lavoro…” Questo abbattimento morale ha risvolti psicologici che gli impongono di rovesciare il tavolo. Ha superato la quarantina e si rende conto che ciò per cui ha lavorato non basta a garantirgli quel posto nella storia che tocca ai profeti. Sotto il profilo psicologico, sia pure per ragioni diverse, è un percorso che ha segnato anche l’esistenza di un altro grande architetto americano che gli viene di solito paragonato (a mio parere immeritatamente), Frank O. Gehry, che chiese aiuto alla psicoanalisi e poi cambiò radicalmente approccio all’architettura ritrovando la propria condizione, a suo modo anch’essa profetica.
A Fiesole, nota Nardi, molte ramificazioni anche progettuali portano a Taliesin: “La casa fiesolana dialoga con una tradizione diversa da quella giovane delle Prairie House… Non troviamo la classica articolazione fluida di spazi attorno al corpo centrale del camino. Nella casa-studio di Fiesole gli spazi si organizzano in sequenze anche se resta al centro, al piano terra, una hall molto più aperta nella comunicazione tra le corti della casa che non nella comunicazione degli ambienti coperti”. Avendo avuto modo, ormai molti anni fa, negli ultimissimi della sua vita, di incontrare due volte Giovanni Michelucci nella sua abitazione-studio a Fiesole, la descrizione della casa wrightiana mi sembra tener conto delle radici del luogo e mi domando se mentre la progettava l’architetto americano non abbia tenuto conto della tipologia della casa toscana che segna la storia secolare del posto. Naturalmente, senza forzare il pensiero di Wright, che aveva come primo obiettivo tradurre l’intuizione dello spazio in una nuova architettura. Ma, in qualche misura, la definizione che Wright diede della sua casa a Fiesole e di Taliesin come “nido d’aquila in cima alla montagna”, penso che si potrebbe applicare anche alla casa che Michelucci abitò dal 1958: era stata edificata negli anni Trenta del Novecento su un terreno ripido e scosceso, da cui si può godere attraverso una loggia una delle viste più suggestive di Firenze dall’alto. D’altra parte, lo stesso Wright abitò in quello che era noto come Villino Belvedere, dalla cui loggia era possibile ugualmente affacciarsi sul panorama fiorentino. All’epoca il territorio fiesolano e le numerose case in esso disseminate erano per lo più popolate da stranieri. E per Wright, scrive Nardi, “Fiesole fu un rifugio ideale come poi lo sarà Taliesin”. Per quanto volesse tenere nascosta l’influenza che il soggiorno in Toscana ebbe sulla sua progettazione, una traccia secondo Nardi resta nei disegni per la casa della sorella, eseguiti nel 1911, dove fra cipressi, corti cintate, terrazze che anticipano l’edificio principale, ritornano spunti che Wright aveva potuto già introiettare vedendo Villa Medici. Ebbe, insomma, un interesse per le ville fiorentine? Si avvertiva vagamente anche nel progetto irrealizzato per la sua casa-studio fiesolana. A Fiesole, conclude Nardi, prende forma il prototipo di Taliesin. E scusate se è poco.
al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.
ABBONATI A
FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Maurizio Cecchetti
Maurizio Cecchetti è nato a Cesena il 13 ottobre 1960. Critico d'arte, scrittore ed editore. Per molti anni è stato critico d'arte del quotidiano "Avvenire". Ora collabora con "Tuttolibri" della "Stampa". Tra i suoi libri si ricordano: Edgar Degas. La vita e l'opera (1998), Le valigie di Ingres (2003), I cerchi delle betulle (2007). Tra i suoi libri recenti: Pedinamenti. Esercizi di critica d'arte (2018), Fuori servizio. Note per la manutenzione di Marcel Duchamp (2019) e Gli anni di Fancello. Una meteora nell'arte italiana tra le due guerre (2023).